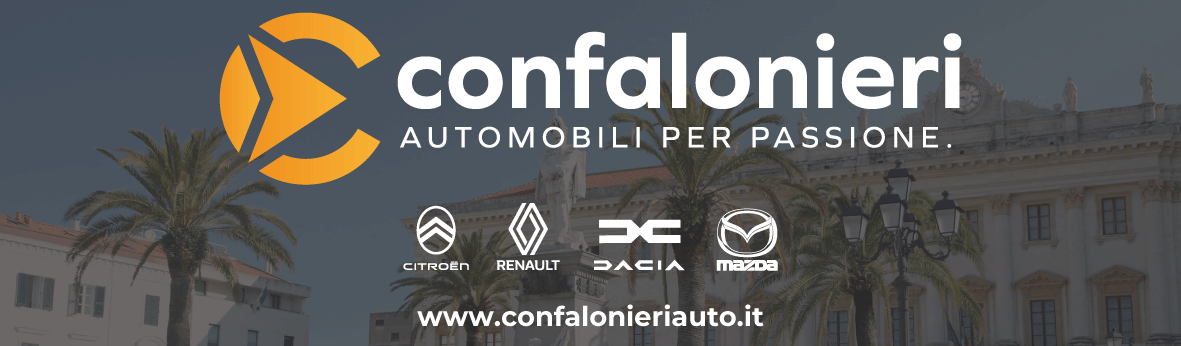L’eredità morale e politica di Enrico Berlinguer
L’intervento del professor Omar Chessa alla cerimonia in ricordo di Enrico Berlinguer di mercoledì 25 maggio all’Università di Sassari

Sassari. Di seguito il testo dell’intervento del professor Omar Chessa, ordinario di diritto costituzionale al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, alla cerimonia in ricordo di Enrico Berlinguer di mercoledì 25 maggio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Signor Presidente della Repubblica, Signor Ministro dell’Università e della Ricerca Signor Presidente della Regione, Magnifico Rettore,
Il titolo della prolusione sembra suggerire che in Berlinguer sia possibile distinguere un’eredità politica da una morale. In realtà, l’eredità è una sola e si tratta perciò di un’endiadi. È questa, a mio awiso, la cifra specifica del lascito berlingueriano. Non c’è un’eredità politica che non sia anche morale, e viceversa. Pur essendo un lettore attento di Machiavelli, da cui prende le mosse la tradizione del realismo politico, Berlinguer non postulava la separazione tra politica e morale, cioè l’idea che la prima abbia proprie leggi e una sfera autonoma rispetta alla seconda.
Qui uso il termine “morale” in senso ampio, ricomprendendo sia la morale individuale, cioè la coscienza che ciascun individuo ha della propria libertà e dei limiti alla stessa, sia, soprattutto, la morale pubblica o meglio: l’etica pubblica, intesa come una sfera obiettiva di valori condivisi, come una base assiologica comune che tiene assieme le comunità umane e le società politiche. È la morale intesa come Sittlichkeit, eticità e “spirito oggettivo”, sulla scia di Hegel: un filosofo che, infatti, Berlinguer aveva studiato a fondo e che indubbiamente amava, come del resto era comune a molti marxisti, tanto da voler fare sul suo pensiero giuspolitico la tesi di laurea in filosofia del diritto.
E in ciò sta, probabilmente, un profilo del lascito berlingueriano di estremo interesse, e per certi versi anche il più innovativo rispetto alla tradizione marxista di provenienza. Berlinguer aveva capito che la politica democratica richiede presupposti particolarmente impegnativi di etica pubblica. Non basta proclamare i diritti individuali, le libertà civili, secondo una visione atomistica della società di mercato. La nota affermazione di Margaret Thatcher “non esiste la società, esistono soltanto gli individui” è, a mio avviso, la negazione esatta della connotazione morale che Berlinguer assegnava alla prassi politica democratica, la quale infatti deve presumere che le comunità politiche non siano soltanto una mera sommatoria di individui che si relazionano tra loro attraverso lo scambio di mercato. Invero, oltre ai diritti individuali ci sono istanze etiche obiettive, che valgono di per sé e non perché gli individui le traducono in pretese soggettive. Non tutto deve reputarsi disponibile, negoziabile e perciò suscettibile di transazione economica, secondo la legge della domanda e dell’offerta e quindi nella misura in cui le preferenze valutative individuali si accordino nel conferire valore.
Ma era proprio questa la deriva cui stava iniziando ad andare incontro la società italiana tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta: una deriva che le riflessioni berlingueriane rilevavano con preoccupazione. Erano gli anni in cui si affermava una sorta di “soggettivizzazione del valore”, secondo cui al di là delle libere inclinazioni soggettive non fosse possibile rinvenire una eticità condivisa e sedimentata nel costume individuale, sociale e politico.
Berlinguer, inoltre, avvertiva che il nesso necessario tra democrazia e moralità pubblica non può essere estraneo alla dimensione privata. Una politica democratica è credibile e autentica se si traduce anche in una condotta personale di vita e se alle affermazioni pubbliche degli uomini politici corrispondono coerenti comportamenti privati degli stessi. Non ci può essere una scissione tra agire pubblico e postura privata. Sotto questo profilo lo “stile di Berlinguer” fu esemplare. Norberto Bobbio, in un articolo comparso nell’Unità del 12 giugno 1984, scrisse che la «caratteristica fondamentale» di Berlinguer era di «non avere i tratti negativi che contraddistinguono tanta parte della classe politica italiana»: la «vanità», l’«esibizionismo», il «desiderio di primeggiare». La sua vita privata era nettamente separata da quella pubblica. La sua convinta e tenace riservatezza era una condizione imprescindibile del suo agire come politico.
Berlinguer credeva fermamente nel legame indissolubile tra politica e cultura. La riconquista di una politica di qualità non poteva che passare attraverso la cultura. Leggeva molto, specialmente i classici della filosofia. Nel corso della sua vita aveva riletto spesso i Dialoghi di Platone e le opere di Machiavelli. La musica, in particolare quella di Wagner, lo incantava. Il nostro lavoro – diceva -non potrà prescindere dall’incontro con le forze «creative per definizione, con le forze intellettuali, della cultura». E perciò gli sembrava naturale che il primo passo di ogni politico fosse un’ottima formazione, una solida base culturale.
Insomma, lo “stile Berlinguer” si caratterizzava per il rigore, la serietà, la sobrietà, l’equilibrio, lo studio approfondito, l’insofferenza per la superficialità. Non tentò di conquistare la scena televisiva, di studiare le nuove tecniche di comunicazione e anzi di fronte alle telecamere e ai flash appariva quasi imbarazzato. Di qui la tesi, purtroppo molto diffusa, secondo la quale Berlinguer proponeva un modo di fare politica ormai superato dalla modernità. Anche all’interno del suo partito una parte dei dirigenti lo considerava legato, sì, ad una visione nobile della politica come servizio e abnegazione, ma, al contempo, limitata e tutto sommato conservatrice, non in grado di cogliere, sino in fondo, i caratteri del tempo a venire.
E invece il segretario del PCI aveva colto meglio e più di altri i pericoli della modernità, i rischi, in particolare, a cui andavano incontro i sistemi democratici. Quel suo insistere sulla questione morale non aveva l’obiettivo di imporre il primato astratto dell’etica alle sfide reali della politica. Come già detto, si trattava di un’operazione più complessa, che guardava alle basi di legittimazione dello Stato e che aveva l’intento di salvaguardare la classe politica, i partiti, le istituzioni, e quindi la stessa democrazia italiana. Berlinguer coglieva la necessità di ricostruire, o quantomeno di riformare profondamente, il rapporto tra governanti e governati. Capiva che la distanza tra “Paese legale” e “Paese reale” si stava facendo troppo ampia. E sentiva i pericoli che questo avrebbe comportato. «I partiti non fanno più politica» – avvertiva in una intervista del 1981, giustamente divenuta importante. «I partiti di oggi – proseguiva – sono soprattutto macchine di potere e di clientela: scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente (…) programmi pochi o vaghi, sentimenti e passione civile, zero. Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune».
La sua diagnosi era precisa, senza infingimenti, ma non perché pensasse che la democrazia italiana potesse cambiare in meglio senza un ruolo forte dei partiti. È assai discutibile intravedere in Berlinguer l’inizio di una deriva, che poi avrebbe alimentato la sfiducia complessiva nei confronti della classe politica. È fondato, invece, trovarvi la difesa di un modo di agire proprio di una generazione, quella che aveva conosciuto la Resistenza. Ciò non può essere considerato, semplicisticamente, un segno del conservatorismo berlingueriano e della sua mancata innovatività. In realtà, egli individuò, come mi sembra nessun altro leader politico di allora, la rilevanza dell’etica pubblica come fondamento irrinunciabile della legittimità di azione dei governanti.
E il rigore di Berlinguer si espresse in molti modi e occasioni. Contro il terrorismo la sua fermezza si dimostrò assoluta. E questo gli costò, sia in termini politici che personali. In quel terribile 1978 perse il suo principale interlocutore, Aldo Moro, ma la difesa della Repubblica, dei suoi principi e delle sue leggi, aveva la priorità, anche sulla vita dei singoli. Per lui era intollerabile l’immagine di una classe politica che trattava con i terroristi. E la sua fermezza contribuì certamente alla sconfitta delle Brigate Rosse e al superamento di uno dei momenti più difficili della storia dell’Italia repubblicana.
Un’altra parola chiave dell’eredità di Berlinguer è «austerità». È una linea che emerge nel 1977 e che pertanto va contestualizzata storicamente: non può interpretarsi retrospettivamente, con le categorie del presente.
Adesso con la parola “austerità” si evocano le politiche di severa restrizione fiscale che seguirono alla crisi finanziaria del 2011. E il giudizio sulla loro utilità ed effetti è largamente critico, com’è noto. Hanno determinato stagnazione produttiva e aggravato il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile, senza significativi risultati in ordine al risanamento dei bilanci pubblici (e anzi, in taluni casi deteriorando ancor più il rapporto tra debito e PIL). Si è fatta strada la tesi che furono un errore.
Orbene, è legittima l’assimilazione alla linea berlingueriana del 1977? Stiamo parlando della stessa cosa?
A mio avviso, no. Anzitutto, perché l’austerità del ’77 era proposta in un contesto fortemente inflazionistico, mentre quella del 2011 in un contesto deflazionistico, Ma soprattutto perché l’idea berlingueriana di “austerità” si legava strettamente alla questione morale. Era, infatti, la critica del «consumismo individuale esasperato», che «produce non solo dissipazione di ricchezza e storture produttive, ma anche insoddisfazione, smarrimento, infelicita» (e sono le parole di Berlinguer). L’analisi era sempre la stessa: il problema, cioè, era l’individualismo possessivo della società di mercato, la sfrenatezza edonistica della propensione individuale al consumo, ormai sdoganata. Tutto questo, a giudizio di Berlinguer, corrodeva l’etica pubblica e sfilacciava il legame sociale, con tutto quel che ne derivava: e cioè, «gli sprechi, i consumi privati superflui, (…) la dinamica perversa della spesa pubblica» (e sono le parole di Berlinguer). Il problema, quindi, non era la spesa pubblica in sé, come invece è propugnato dalle dottrine deN’«austerità espansiva» in voga sino a un paio di anni fa e ancora pronte a riproporsi: bensì la sua «dinamica perversa»; l’uso, cioè, della spesa pubblica in chiave improduttiva e in modo regressivo sotto il profilo fiscale e redistributivo. Ma se la questione morale si ricollega al discorso sull’austerità, questa a sua volta si connette, direi quasi naturalmente, alla questione ecologica, che Berlinguer ebbe il particolare merito di proporre tra i primi nel dibattito pubblico italiano. Questo è un aspetto che raramente viene sottolineato come meriterebbe. Forse lo aveva in tal senso supportato il fratello-Giovanni, che era particolarmente sensibile ai temi e ai problemi dell’ambiente. Certo è che egli si rivelò un precursore. Neanche la Costituzione, come si sa, dedicava alla questione ambientale uno spazio adeguato. Una lacuna cui si è rimediato solo di recente, con la legge costituzionale n. 1 del 2022, che ha profondamente modificato l’art. 9, inserendo l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità tra gli obiettivi di tutela costituzionale.
La cultura comunista tradizionale trascurava il pensiero ecologista. Nel 1979 Berlinguer, al XV congresso del Partito, comprese che era necessario porre il problema dell’interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente. Non c’era ancora una vera e propria cultura ambientalista, ma si intravedeva un percorso che il segretario si incaricava di indicare. Berlinguer coglieva il senso dei grandi processi, dei mutamenti del mondo, con uno sguardo ampio, con i “pensieri lunghi”, come Umberto Gentiloni Silveri ha messo in evidenza in un libro dedicato al politico sardo. E tra i “pensieri lunghi” di Berlinguer c’era quello che riguardava la collocazione internazionale del partito comunista e della Repubblica italiana.
Sotto la sua guida il PCI conobbe un’evoluzione importante. Cambiarono i rapporti con l’Unione Sovietica e si prepararono significative aperture nei confronti degli Stati Uniti. Ma il dato più importante, forse, è che si guardò all’Europa in modo nuovo. Con Berlinguer il PCI iniziò a maturare una coscienza europeista. Nel 1976 il segretario propose ad Altiero Spinelli di candidarsi nelle liste comuniste. Dimostrò coraggio, molto più di quanto alcuni a suo tempo gli riconobbero. Nel novembre 1977, a Mosca, sessantanni dopo la rivoluzione d’Ottobre, riaffermò i valori della libertà, della democrazia, del pluralismo. Certo, mancò una rottura totale con il socialismo sovietico. Nei fatti, però, la distanza, anche sotto il profilo ideologico, era abissale, come dirò tra poco con riguardo al problema del capitalismo. L’autonomia del PCI berlingueriano, in campo internazionale, non fu mai effettivamente in discussione. La sua prospettiva, forse in qualche misura velleitaria, era di coniugare socialismo e europeismo sotto la bandiera dell’eurocomunismo. La ricerca di questa strada nella sostanza fallì, ma il suo impegno in politica estera lasciò ai posteri un messaggio carico di coraggio e di idealità per la pace, per il disarmo, per il superamento dei blocchi.
Chiudo con un tema cruciale: Berlinguer e il capitalismo. Il tema è cruciale perché Egli fu il leader del più grande partito comunista dell’Occidente democratico e capitalista e lo fu negli anni in cui il partito otteneva i consensi elettorali più grandi di tutta la sua storia (superò il 34% nelle elezioni politiche del 1976 e in quelle europee del 1984, subito dopo la morte di Berlinguer e forse anche sull’onda emotiva dell’evento, superò la DC con oltre il 33% dei voti). Ebbene, quale fu, infine, la posizione di Berlinguer sul capitalismo? Direi che se consideriamo l’evoluzione dei primi anni Ottanta fu un approccio perfettamente in linea con la Costituzione italiana. Anzi, direi che era il medesimo approccio. Nella intervista a Scalfari del 1981 l’orientamento non è più fieramente e rigidamente anti-capitalistico. È certamente critico nei confronti di questo modo di produzione, ma è lo stesso atteggiamento critico che si evince dal dettato costituzionale, il quale infatti riconosce, a un tempo, la legittimità e i limiti del capitalismo.
Per un verso Berlinguer ritiene (e qui riporto le sue testuali parole) che «il tipo di sviluppo economico e sociale capitalistico sia causa di gravi distorsioni, di immensi costi e disparità sociali, di enormi sprechi di ricchezza». Ma subito dopo precisa (sempre testuali parole) di non voler «seguire i modelli di socialismo che si sono finora realizzati», cioè «una rigida e centralizzata pianificazione dell’economia»: e ciò nel presupposto che «il mercato possa mantenere una funzione essenziale, che l’iniziativa individuale sia insostituibile, che l’impresa privata abbia un suo spazio e conservi un suo ruolo importante» (e pure queste sono le parole effettivamente usate da Berlinguer). La sua proposta era, infine, quella di «discutere in qual modo superare il capitalismo inteso come meccanismo, come sistema» che creava «masse crescenti di disoccupati, di inoccupati, di emarginati, di sfruttati».
Per Berlinguer, insomma, la questione non era se dovesse esserci il capitalismo, ma quale capitalismo. In ciò sta, a mio avviso, il più grande elemento di novità della sua riflessione insieme politica e morale.
In conclusione, l’eredità di Berlinguer, in molti suoi tratti, appare ancor’oggi scomoda, intensamente collegata ai sacrifici personali e collettivi, ma destinata a essere largamente apprezzata dal “Paese reale”. Al di là dei giudizi di conservatorismo, quel politico nato a Sassari cento anni fa ci appare profondamente moderno. Il suo tentativo, evidentemente riuscito, di coniugare rigore morale, abnegazione e politica democratica rappresenta un modello di riferimento senza tempo. Per tutte queste ragioni il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari ha proposto all’Ateneo di conferire un attestato di benemerenza a Enrico Berlinguer, che fu studente brillantissimo della allora Facoltà di Giurisprudenza: infatti, prima di trasferirsi alla Sapienza di Roma sostenne a Sassari 15 esami su 22, tutti con la media di 30/30 e cinque lodi. Chiese di fare la tesi di laurea sulla filosofia del diritto pubblico di Hegel, tesi che purtroppo non fu mai completata. Ma ponendo nella maturità politica la “questione morale”, e ponendola con più forza di chiunque altro, è sicuro che Berlinguer avesse ben appreso la lezione hegeliana.